'A proposito di vino…'
Il vino e gli italiani secondo Franco Maria Ricci, presidente dell’Associazione italiana Sommelier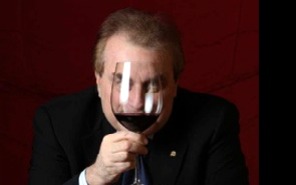
di Elisabetta Marinelli
“Sono 7 milioni e mezzo gli italiani che conoscono il vino, i restanti 53 non sanno cos’è. Parlo di vino di qualità, naturalmente. Eppure, il vino appartiene alla nostra cultura in modo enorme, per storia e per tradizione. L’Italia ha una produzione incredibilmente diversificata, da Sondrio a Caltanissetta assistiamo a una magia di mille sapori diversi...Ma gli italiani non conoscono il vino…” - Secondo lei perché? – “L’Italia è un Paese strano. Il vino di qualità rappresenta la prima voce dell’agro-alimentare e la seconda voce attiva della bilancia dei pagamenti con 17 miliardi e mezzo di fatturato l’anno. Nonostante questo non riusciamo a far capire a chi è preposto l’importanza e il valore di far avere agli italiani un minimo di cultura del vino. Che è rimasto anche l’unico made in Italy”. –Sarà per questo che negli ultimi anni abbiamo visto nascere i Winebar, tra l’altro gestiti spesso da giovani…made in Italy, quindi anche trendy- “In un certo senso sì…Ma c’è anche un altro aspetto meno ‘modaiolo’ e più legato alla riscoperta di qualcosa. Oggi molti giovani scelgono il vino al posto del cocktail, fanno l’aperitivo con un buon bicchiere di vino perché lo apprezzano, ne riconoscono le qualità…E chi sceglie di aprire un locale, una bottega , un Winebar è qualcuno che in qualche modo dal vino è stato rapito. Conosco tante storie…”.
Franco Maria Ricci, direttore dell'A.I.S.(Associazione Italiana Sommelier) di Roma e presidente della WSA, l’associazione mondiale dei Sommelier, ha conosciuto la storia di chi, ottenuto il diploma di sommelier, ha deciso di aprire un’attività legata al vino lasciando posti sicuri e ben retribuiti. Si tratta di persone che, man mano che conoscevano i segreti del vino, ne venivano rapite. Perché “il vino ti cambia la vita. E’ un’arte. E l’arte, quando la scopri, non ti lascia più”.
Un’arte che in pochi (o in troppo pochi) apprezzano, considerato che i numeri del vino di qualità made in Italy, in realtà, sarebbero meno incoraggianti dei 17 miliardi e mezzo di fatturato l’anno cui fa riferimento Ricci. Una buona fetta è rappresentata dall’export, primo fra tutti il mercato Usa, dove il nostro vino, negli ultimi anni, si è guadagnato il primato. Ottime le performance nel mercato Giapponese. In patria- a parte la tendenza ultima confermata dall’Istat, che nel 2010 vede i vini DOC e DOCG resistere alla crisi molto meglio dei vini da tavola- si trova invece a cedere un po’ il passo a una variegata concorrenza che comprende anche il prodotto in tetrapak. Sulla tavola delle famiglie italiane il vino non manca; il 'fiasco' è nell’immaginario collettivo tanto quanto il piatto di spaghetti o il pane. La vite fu sull’Arca di Noè e il vino ebbe a che fare con il primo miracolo compiuto da Gesù (nozze di Canaa) e con l’unico miracolo che la Madonna abbia chiesto a Gesù. Se ne parla come del ‘nettare degli dei’ e la Storia ci rimanda le cronache di Plinio il Vecchio. Fa parte, insomma, di una certa tradizione, che è anche la nostra. Ma “il consumo di vino in Italia non è molto orientato alla qualità- spiega Ricci- Il tetrapak…va bene anche spendere 1 euro, va bene tutto. Perché non si sa quanto deve costare un vino. Tutti sanno bene quanto deve costare il cappuccino al bar e l’insalata al ristorante, nessuno sa quanto deve costare un vino. Nel nostro Paese non si sa cosa vuol dire provare un’emozione davanti a un bicchiere di vino.” -Prima ha parlato di mancanze di chi è preposto a farlo conoscere. Si riferiva, per esempio, alle scuole? - “I problemi nascono anche da lì. In 5 anni di programma, la scuola alberghiera italiana prevede solo 5 ore di insegnamento sul vino. In Francia è materia di studio in tutte le scuole dal 7°-8° anno. E poi, da noi se ne parla poco in generale, sui giornali, in televisione ”.
Eppure, in Italia non sono pochi gli appassionati del vino. Almeno stando agli iscritti all’A.i.s, che conta oltre 31.000 sommelier. 31.000 persone ufficialmente mosse dalla passione per il vino. “Chi viene a fare i corsi per sommelier lo fa prima di tutto per se stesso. E’ un modus vivendi. Se poi diventa il suo lavoro, quella è una cosa in più”. Due anni di corso per imparare la storia, i sapori, gli odori, le sfumature, il ‘pensiero’ di un vino. E alla fine, saperlo riconoscere e ‘raccontare’. Il primo sommelier italiano ‘dell’età moderna’ risale a 45 anni fa, quantomeno il primo sommelier certificato. Coincide con la nascita dell’Associazione italiana Sommelier e viene dall’esigenza di comunicare il prodotto nel ristorante. Il cameriere non bastava più e bisognava creare professionisti che sapessero spiegare il vino. “E’ capitato anche in altri settori- dice Ricci- Per esempio, nei supermercati 15/20 anni fa il pesce lo vendeva il commesso. Poi è arrivato il ‘pesciarolo’, un professionista con conoscenze specifiche, capace di trattare il pesce e di dare assistenza al cliente. La stessa necessità c’è stata per i ristoranti…” –Questo risponde alle esigenze di mercato. Ma esiste una vocazione, la vocazione del sommelier?- “Una vocazione che porta con sé arte e cultura. Poi serve passione. Sono le basi per essere ‘arbitri’ della bontà del vino, per saper riconoscere la qualità nel bicchiere, non l’etichetta. Il sommelier di professione è il tramite tra il produttore e il consumatore come indicatore di qualità. E c’è un’altra caratteristica importante che deve avere: l’eleganza. Il rapporto con il vino deve essere rispettoso, anche nel modo di versarlo in bicchiere. Un vero sommelier non avrà mai un atteggiamento altezzoso o supponente”. –A proposito di vino come arte e cultura. E’ vero che i francesi sono più bravi di noi?- “Sono arrivati 100 anni prima…questa è la differenza. Tra 100 anni saremo bravi esattamente come loro. Ma già oggi siamo migliori nel segmento medio-basso. Sul medio-alto loro sanno come venderlo, come farlo, come produrlo. La differenza, semmai, sta nel livello di cultura, di conoscenza del vino. Torno a dirlo: da loro si studia a scuola già dal 7° anno. Abbiamo un grande patrimonio e lo ignoriamo. Il nostro è un Paese dalla terra magica. Lo chardonnay, per esempio, non è un vitigno italico. Ma se lo coltiviamo in Sicilia, se il vino Tasca D’Almerita sa di zagara, quello è un vitigno autoctono. Ecco: la nostra terra ci dà l’opportunità di ‘sentire’ tanti sapori diversi, di scoprire mille combinazioni straordinarie che creano qualcosa di nuovo, unico. Peccato non saperlo”.