'I diavoli di via Padova. Cronaca di un inferno annunciato'
Matteo Speroni racconta la vita di via Padova a Milano, un laboratorio in cui si sperimenta sul campo l’integrazione, un angolo straordinario e particolare assurto alle cronache con i fatti di sangue costati la vita a un 19enne egiziano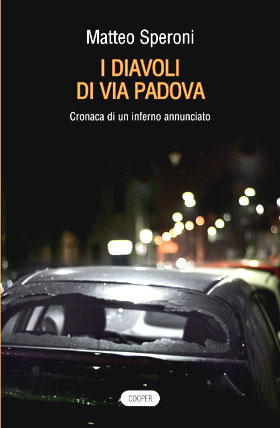 di Carla Toffoletti
di Carla Toffoletti
Via Padova, a Milano, è un'umanità che parla lingue diverse. In 'I diavoli di via Padova. Cronaca di un inferno annunciato', attraverso il protagonista, Tes, un perdigiorno senza lavoro e senza mete, Matteo Speroni ci porta nei bar gestiti da cinesi e frequentati da latinos e marocchini, negli empori di indiani aperti fino a notte fonda, in case fatiscenti abitate da trans, pusher, tossicodipendenti. Storie dure, tra disperazione e violenza, riscatto, droga, azzardo e miseria.
Perché un libro su via Padova?
Ho iniziato a scriverlo più di un anno e mezzo fa, perché abito lì da vent’anni. E’ la mia terra, la mia zona. Stando lì, andando in giro per il quartiere mi sono accorto che tante delle persone che incontravo meritavano una storia. Mi piace scrivere e ho dato vita al libro.
Perché un romanzo?
Credo che solo un romanzo possa raccontare anche la dimensione psicologica più profonda, al di là dell’inchiesta giornalistica o dello scritto di sociologia. Mi sono appassionato a questa avventura, che è durata un bel po’. L’ho scritto, affinato, fino a quando, il 13 febbraio scorso, in seguito all’uccisione di un immigrato egiziano, la mia via è finita su tutte le cronache dei giornali. Casualmente coincideva con la fine della stesura del mio libro. Nel tuo libro racconti una Via Padova diversa da quel ghetto violento descritto dai giornali.
Qual è la “tua” via Padova?
E’ un quartiere che ha una situazione sociale piuttosto anomala e di avanguardia in Italia. E’ multietnica per davvero. E’ una via in cui ci sono immigrati da tutto il mondo, Sudamerica, India, Bangladesh, Est Europa, Centrafica, Nordafrica. La mia via Padova è una via fatta di storie dure, di disperazione, anche di illegalità e di violenza. Situazioni di disagio sia abitativo che sociale, portano a esiti molto forti. Però è una via carica di passione, di sofferenza e di coraggio, di confronto molto vero e profondo tra le persone. Mi sono appassionato alle storie umane e a quella che per me è la vera integrazione: il confronto umano. Qui il confronto è reale, pur nelle difficoltà, proprio perché ognuno deve convivere con la propria storia a volte molto dura. E’ un quartiere in cui non ti annoi E’ un quartiere in cui si sperimenta l’integrazione ma anche l’intolleranza.
C’è una frase del libro che mi ha colpito. Tu fai un sorta di excursus di quella che è stata via Padova negli anni, ricordi il Leoncavallo, Radio Popolare, il covo Br in via Montenevoso, e poi scrivi: “Tutto è accaduto da queste parti, in questi palazzi, poi rimasti in silenziosa attesa per due decenni, le finestre socchiuse pronte ad aprirsi al nuovo millennio, alle migrazioni del mondo”. Che sfida lancia via Padova all’Italia intera?
La sfida a vincere la paura. Quella alimentata e strumentalizzata a fini politici, la paura per quelli diversi da noi. Una volta erano i migranti dal sud Italia.La paura nasce quando ci si deve confrontare e riequilibrare con le nuove povertà, le nuove sofferenza. La sfida è quella di vincere la paura del chiudersi in se stessi, dell’arroccarsi. Lo sviluppo della storia e la modernità ce la mostrerà come una scelta sbagliata. Bisogna avere controllo, curiosità e desiderio di conoscenza.
Cos’è per te integrazione?
Rispetto e conoscenza. Vincere meccanismi di chiusura e di paura individuale, personale e soggettiva. Nel momento in cui si conosce la storia di una persona , anche quello che in superficie poteva sembrarti inquietante, assume un altro valore. L’integrazione parte dai rapporti personali.
Si rischia in via Padova una deriva tipo banlieu?
No, se non quanto in tanti altri luoghi d’Italia. Via Padova è quanto di più diverso da una periferia abbandonata e monotona..La rissa che ha portato un ragazzo sudamericano ad accoltellare un ragazzo egiziano il 13 febbraio scorso è scoppiata per “futili motivi” e non è stata una guerra tra etnie..Certo il fatto che il quartiere sia veramente multietnico fa emergere in modo molto più duro i contrasti tra culture e stili di vita diversi. E’ difficile che la comunità marocchina trovi affinità con quella peruviana. Solo la convivenza su un territorio e l’accettazione di regole condivise, nel rispetto reciproco, può evitare episodi come quello verificatosi il 13 febbraio.
Nel tuo romanzo il protagonista, Tes, dice al giornalista che si appresta a fare un inchiesta : “Che cosa vuoi scrivere? Che qui è pieno di stranieri e di violenza, parlare di alcol e droga, o vuoi raccontare che tanta gente diversa vive nello stesso quartiere? “. E’ un’accusa a come la stampa spesso affronti in modo superficiale fatti che hanno una valenza molto più articolata e complessa?
Faccio anch’io il giornalista. Quello che sento mancare oggi è l’inchiesta di ampio respiro. Ci si butta sul fatto e lo si mastica nelle sue immediate manifestazioni. L’inchiesta di grande respiro permette di approfondire e di non dare giudizi affrettati. Spesso ci si lascia prendere dalla superficialità dei fatti.
Nel romanzo definisci via Padova un “fiume Padova a corrente umana continua”. Cosa vuoi dire?
Se vieni in via Padova di domenica, giorno in cui parte l’ambientazione del libro, trovi un sacco di gente che cammina, che passeggia, che si muove. Il fiume, a differenza del mare, è in movimento ed è composto da tanti movimenti diversi. E’ una metafora dei colori, delle etnie, della diversità umana di chi compone via Padova. Il fiume è qualcosa in continua evoluzione. O ti sintonizzi con la sua corrente o rischia di travolgerti e di farti paura.
Come vivi in via Padova?
Molto bene, ho tanti amici , se ho un problema qualcuno me lo risolve. Bisogna non avere pregiudizi, saper stare con tutti e cercare di trovare il meglio anche dalle persone che apparentemente potrebbero sembrarti inquietanti.