Alessandro Pavolini, da intellettuale a gerarca
Nel romanzo del nipote Lorenzo, 'Accanto alla tigre', un racconto familiare con le storie personali intrecciate strettamente alla Storia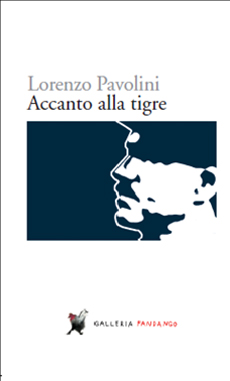 di Raffaella Miliacca
di Raffaella Miliacca
A 12 anni, Lorenzo, guardando una foto sul libro di storia, scopre una verità fino ad allora sconosciuta. Tra i gerarchi appesi a testa in giù insieme al Duce, a Piazzale Loreto, c’è suo nonno, Alessandro Pavolini, ministro della Cultura del regime e segretario del Partito Fascista durante la Repubblica di Salò. Di quel nonno, in famiglia, si diceva genericamente “morto in guerra”.
“Accanto alla tigre”, di Lorenzo Pavolini (ed. Fandango), tra i finalisti del Premio Strega, è il racconto di questa scoperta e del suo procedere, nella complessità di fare i conti con una difficile eredità. Diventato adulto, Lorenzo è sollecitato da più parti e da una serie di segnali a scandagliare la figura di Alessandro Pavolini, “scrittore e squadrista”, “raffinato intellettuale fiorentino” e fondatore delle Brigate Nere. Mentre lui, con quel “morto in guerra” che gli era stato raccontato, da ragazzino se lo era immaginato come un aviatore alla Saint-Exupéry.
Nel libro c’è il racconto familiare, con le storie personali intrecciate strettamente alla Storia, ci sono le testimonianze dell’epoca, gli scritti, i filmati, e c’è il progressivo accostarsi dell’autore all’ingombrante personaggio del nonno. Si avverte che il percorso è stato difficile e sofferto, e iniziato con una certa riluttanza, ma probabilmente inevitabile perché quel pezzo di storia di famiglia, per Lorenzo, non restasse in sospeso e gli permettesse di camminare “accanto alla tigre”.
Allo scrittore abbiamo chiesto come è stato affrontare la figura di Alessandro Pavolini.
Molto impegnativo. Ma, soprattutto, è stato molto complicato il rapporto con la mia famiglia attraverso mio nonno, perché ho scritto un libro su di lui mentre sono vivi mio padre e altri figli. La grande difficoltà è stata confrontarsi con una persona che non ho mai conosciuto, mentre sono in vita persone che ne hanno subito la perdita. Ho potuto quindi lavorare con una certa distanza che non possono avere altri miei familiari. Mi sono trovato a scrivere un romanzo sulla mia famiglia che non può essere un romanzo familiare.
Nel libro si avverte una certa riluttanza ad accostarsi all’argomento, la sensazione che il lavoro sia nato più da sollecitazioni esterne. E’ così?
Il romanzo mette in scena proprio questa riluttanza, per due motivi. Il primo è perché chi appartiene a una famiglia non è detto che ne sappia più di altri. Questo è il classico caso in cui gli storici o chi ha scritto su mio nonno lo conosce meglio di quanto lo conoscessi io fino a poco tempo fa. Il secondo motivo è dato dal fatto che il fascismo non è una storia con cui è piacevole confrontarsi, soprattutto il dover studiare i suoi fondamenti culturali, il doversi occupare di un protagonista di un pensiero, di una cultura che non si ama e di cui si è felici che l’Italia si sia liberata. La tecnica usata nel libro fa capire che avevo scelto di rimanere a una certa distanza e di basarmi su questo tipo di ricerca: non tanto esprimere giudizi o valutazioni dirette, ma capire da quale distanza ci può parlare oggi una storia. La scelta di stare accanto a un tema, a una figura, piuttosto che affrontarla direttamente, l’ho fatta proprio per vincere la reticenza a raccontarla. Su argomenti come quelli del Ventennio, soprattutto gli ultimi tre anni della guerra, è stato scritto molto, siamo andati molto avanti nella sua comprensione. Quello che a volte manca è il cercare di portare avanti un dialogo che tenga dentro anche i dubbi. Per questo, nel libro ho scelto una forma corale, ci sono sempre degli interlocutori, come se avessi bisogno di tenermi per mano con qualcuno nell’affacciarmi su qualcosa che un po’ spaventa.
Quanto è stata lunga la gestazione del romanzo?
Per molti anni non mi sono fatto convincere da nulla ad occuparmi realmente di Alessandro Pavolini. Cinque, sei anni fa ho accettato di cominciare a parlarne approfonditamente con alcune persone. Sono partito dal consiglio che mi ha dato Enzo Siciliano:lavorare sui libri di Pavolini, considerare le sue pagine come lo specchio dell’anima di uno scrittore, come diceva Moravia. Mi sono avvicinato a lui secondo diverse strategie e mi sono trovato di fronte a qualcosa di molto impegnativo da penetrare. La sua storia contiene lo squadrismo, le Brigate Nere, la fucilazione, e il modo in cui viene proposta in alcuni casi la sua figura, come se fosse un eroe. Accanto a questo, c’è l’Alessandro Pavolini scrittore, intellettuale che a Firenze, quando era federale, ha fatto tante cose, come ideare il Maggio Musicale Fiorentino. Non sono andato a parlare con i grandi storici o persone della mia famiglia, ma con chi per un motivo o per l’altro lo conosceva, come Fulvio Abbate, Antonio Pennacchi e altri amici, per trovare la giusta chiave di accesso.
La figura di suo padre entra nel racconto in maniera molto discreta, ma intensa, solo alla fine del libro. Perché?
Nel piano del libro, la mia idea era quella di stare al di fuori della famiglia per poi tornare a mio padre. Negli ultimi due capitoli ho raccolto anche le sue reazioni, i suoi ricordi. Mio padre, ancora più di mio nonno, è stata la persona con cui davvero mi sono confrontato con questo libro. Per me è stato sempre un bambino a cui hanno fucilato il papà quando aveva sette anni. Questo elemento, senza fare nessuna retorica, lo ha posto in una certa condizione nella vita. Il fatto che lui sia riuscito a non trasmettermi nessuna rabbia per questo, nessuna nostalgia, nessun senso di essere reduci, per me è sempre stato importante. E’ stata una lezione di libertà.