Il futuro dell'informazione nell'era di vetro
A colloquio con Massimo Gaggi e Marco Bardazzi, autori del libro 'L'ultima notizia'di Luca Garosi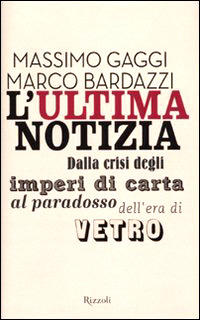 Una nuova generazione si sta affermando: sono i giovani che sono cresciuti con le tecnologie digitali, i "nati digitali" usano quotidianamente il computer, scaricano musica da iTunes, sono iscritti a Facebook dove hanno centinaia di amici con i quali condividono esperienze e sentimenti tramite una chat. Questa generazione ha però poca confidenza con libri e giornali e quando questi ragazzi decidono di informarsi lo fanno in modo diverso dal passato. Anche se si continua a dedicare un’ora della giornata a informarsi, i "nati digitali" ricorrono anche a Internet e spesso i social network diventano porta di accesso alle news. Il sindaco di San Francisco sostiene che se il mondo restasse senza quotidiani "i cittadini al di sotto dei trent’anni nemmeno se ne accorgerebbero".
Una nuova generazione si sta affermando: sono i giovani che sono cresciuti con le tecnologie digitali, i "nati digitali" usano quotidianamente il computer, scaricano musica da iTunes, sono iscritti a Facebook dove hanno centinaia di amici con i quali condividono esperienze e sentimenti tramite una chat. Questa generazione ha però poca confidenza con libri e giornali e quando questi ragazzi decidono di informarsi lo fanno in modo diverso dal passato. Anche se si continua a dedicare un’ora della giornata a informarsi, i "nati digitali" ricorrono anche a Internet e spesso i social network diventano porta di accesso alle news. Il sindaco di San Francisco sostiene che se il mondo restasse senza quotidiani "i cittadini al di sotto dei trent’anni nemmeno se ne accorgerebbero".
La carta stampata è veramente destinata a sparire? Nel futuro ci informeremo soltanto online? Abbiamo parlato di questi argomenti con Massimo Gaggi e Marco Bardazzi, autori di un libro edito recentemente da Rizzoli intitolato "L’ultima notizia". I due autori hanno osservato da vicino, per anni, lo sbriciolamento dei quotidiani americani: Gaggi è inviato del Corriere della Sera a New York e Bardazzi lo è stato per l’Ansa a Washington prima di passare alla Stampa. Nel libro fanno una fotografia del giornalismo statunitense analizzando la crisi "dell’impero di carta", ma soprattutto parlando dell’informazione "nell’era di vetro" che ci sta dando un’informazione più trasparente, anche se più fragile.
Anche se in forte crisi, sono in molti coloro che sostengono che la carta stampata non scomparirà. Come potrà sopravvivere e convivere con il web?
Un po’ come sta accadendo per l’industria automobilistica, anche nell’editoria stiamo andando incontro a modelli “ibridi” che spingeranno i media a essere presenti su piattaforme diverse. L’informazione del futuro passerà attraverso il web (in forme gratuite o con servizi “premium” che richiederanno modalità di abbonamento), su “tavolette” elettroniche, smartphone e altri dispositivi. Ma la carta resterà e avrà un ruolo tutt’altro che secondario. Cambierà con ogni probabilità la natura dei giornali, trasformandoli sempre più in strumenti di approfondimento e di analisi. Si farà più stretto il rapporto, che già oggi esiste, tra il racconto “tradizionale” fatto dal quotidiano e gli approfondimenti multimediali che lo accompagnano. E’ un futuro complesso e in buona parte ancora da inventare, ma se sapremo gestirlo bene è anche un futuro che si presenta di grande arricchimento per l’informazione.
Perché sostenete che la "purezza" della Rete è un mito da sfatare?
Perché non è detto che tutto ciò che nasce e vive solo online, spesso fuori da ogni controllo, sia necessariamente più credibile di ciò che passa al vaglio di una redazione giornalistica, dei suoi filtri, dei suoi metodi di valutazione degli eventi sviluppati nel corso dell’ultimo secolo e mezzo di storia. La Rete porta una ricchezza di contenuti enorme al mondo del giornalismo, che occorre saper sfruttare al meglio. Ma porta anche molto caos, cancella la gerarchia di importanza dei fatti, talvolta scade nel gossip o nella teoria cospirativa. Riteniamo ci sia ancora – e forse ancor più che in passato – un compito importante che spetta ai professionisti dell’informazione, nell’aiutare la gente ad avere a disposizione in un modo organizzato gli elementi di conoscenza che permettano a tutti di fare le scelte che caratterizzano il nostro vivere quotidiano: scelte finanziarie, politiche, di educazione dei figli e via dicendo.
Nel vostro libro prevedete che in futuro ci dovremo abituare a pagare una "bolletta delle news". Tra quanto e in che modo si pagherà per l’informazione on line? Secondo voi questo creerà problemi al popolo della Rete abituato da sempre a usufruire direttamente e gratuitamente delle notizie su Internet?
Pensiamo che non sarà un fenomeno traumatico, né immediato. Ci siamo già abituati in questi anni a pagare per servizi che un tempo non avevamo a disposizione, e che ora fanno parte della nostra vita: pensiamo all’abbonamento per il cellulare, a quello per la Tv satellitare, alla chiavetta per navigare su Internet, ai brani musicali per l’iPod da scaricare su iTunes. Quello che è importante è un graduale cambiamento culturale che permetta di riconoscere il valore di prodotti giornalistici che vadano oltre il normale flusso delle notizie, che resterà comunque gratis.
Cresce la voglia dei lettori di partecipare sempre di più anche alla produzione di informazione. Tanto che la comunicazione del futuro si basa su tre C: condivisione, comunità e conversazione. Come si può certificare l’informazione su Internet?
Affiancando a queste tre “C” - di cui dobbiamo ancora scoprire pienamente le potenzialità – le altre tre “C” che il giornalismo ha già da tempo trasformato nei suoi punti di forza: credibilità, contenuti e creatività. La rivoluzione digitale in corso offre un’opportunità importante ai media per rafforzare caratteristiche come la credibilità dell’informazione, o la solidità dei contenuti. Da questo punto di vista, siamo di fronte all’occasione per la macchina del giornalismo per eseguire un tagliando, ripulirsi anche di molte scorie e ripartire con un motore messo a punto per affrontare le nuove sfide.
Attualmente il citizen journalism sembra funzionare bene nei casi di cronaca (incidenti, tragedie, attentati), mostra tutti i suoi limiti quando si tratta di interpretare l’informazione. Il giornalismo "dal basso" potrà avere un futuro? E in che rapporto starà con il giornalismo tradizionale e professionale?
Il giornalismo dal basso arricchisce l’informazione, la rende più immediata, permette di catturare – grazie al digitale – momenti della realtà che finora potevano essere raccontati solo con un margine di ritardo e affidandosi a testimonianze di vario genere. Pensiamo alle immagini dei terremoti che ci arrivano da ogni parte del mondo. Ma il “citizen journalism” resta un fenomeno di portata limitata quando si tratta di svelare i retroscena della politica, scandagliare il “dietro le quinte” dei consigli d’amministrazione delle grandi imprese, riportare le indiscrezioni dallo spogliatoio di una squadra di calcio. Più in generale, non dobbiamo illuderci che la tecnologia sia sempre la soluzione a tutto. C’è bisogno di chiavi interpretative, e ce ne sarà sempre più bisogno in un mondo che si fa enormemente complesso.
Nel vostro libro avete parlato della situazione negli Usa, qual è lo stato dell’informazione in Italia?
Come in tutte le cose, ci sono luci e ombre. I gruppi editoriali sono più solidi degli “imperi di carta” che franano in altri paesi. La sopravvivenza è meno legata al modello di business basato solo sulla pubblicità, che ha messo in crisi gli Usa. C’è una creatività che spesso manca negli Usa, dove l’approccio al giornalismo è più “scientifico”. Nello stesso tempo, c’è forse una maggiore resistenza al cambiamento, un ruolo della televisione diverso da ogni altra parte del mondo, e soprattutto c’è il rischio di un “digital divide” rispetto a paesi come gli Usa dove si sta correndo molto per inventare l’informazione digital-cartacea del futuro.