'La mafia fa schifo'. Ma ancora non è vinta
Le denunce dei ragazzi nell’ultimo libro sulla criminalità organizzatadi Maurizio Righetti
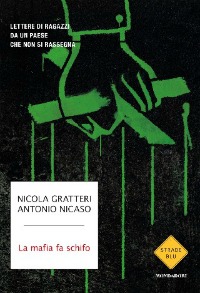 Sono amici da sempre. Insieme sono cresciuti, insieme hanno combattuto e combattono - da fronti in fondo non così lontani - la malavita organizzata. Insieme scrivono anche libri. Con lo scopo primario di diffondere la cultura della legalità. L'ultima loro opera si chiama “La mafia fa schifo''.
Sono amici da sempre. Insieme sono cresciuti, insieme hanno combattuto e combattono - da fronti in fondo non così lontani - la malavita organizzata. Insieme scrivono anche libri. Con lo scopo primario di diffondere la cultura della legalità. L'ultima loro opera si chiama “La mafia fa schifo''.
Si tratta del magistrato antindrangheta Nicola Gratteri, aggiunto nella Procura distrettuale di Reggio Calabria, e del giornalista e scrittore Antonio Nicaso, esperto di mafie, che vive tra il Canada e gli Stati Uniti.
'La mafia fa schifo' raccoglie lettere di ragazzi ed adolescenti. Ne emergono sentimenti di paura, rabbia, desiderio di rivalsa e di ribellione contro la criminalità organizzata. Sono i giovani, stavolta, a raccontare. Testimonianze sconvolgenti di persone colpite dalle cosche o impressionate dalle storie apprese in tv o lette sui giornali.
Gratteri e Nicaso li abbiamo intervistati dopo l'ultimo incontro pubblico con i giovani, all'Istituto Filosi di Terracina, organizzato da Agostino Alla e Glauco Tornesi.
C'è bisogno di un titolo così provocatorio per far capire che la criminalità organizzata è intrinsecamente un male?
Antonio Nicaso. Le mafie sono un fenomeno con cui conviviamo da troppo tempo. Se ai giovani cominciano a fare schifo è un buon segnale. È importante capire che i mafiosi non si combattono solo con le forze dell’ordine e con i magistrati. C’è bisogno del contributo di tutti, contrapponendo la forza della ragione alla ragione della forza.
I precedenti libri sull'argomento hanno raggiunto gli scopi che si prefiggevano? Ed a cosa punta "La mafia fa schifo"?
Nicola Gratteri. Con “Fratelli di sangue” e “La malapianta” abbiamo cercato di raccontare la ‘ndrangheta, un’organizzazione criminale che in Italia è cresciuta nel silenzio e che è diventata ricca e potente. Con “La giustizia è una cosa seria” abbiamo proposto alcune modifiche normative per rendere più efficace la lotta alle mafie, ma anche per migliorare il nostro sistema giudiziario, spesso al centro di polemiche. Con questo libro “La mafia fa schifo” abbiamo pensato di dare voce ai tanti giovani incontrati negli ultimi cinque anni. Sia io che Nicaso dedichiamo ai giovani gran parte del nostro tempo libero, andando nelle scuole. Quello raccontato dai giovani è uno spaccato straordinario, di un Paese che non si rassegna.
Colpisce di più il racconto delle vicende vere - di violenze e poi giudiziarie - o il romanzo comunque incentrato sul tema?
N.G. I ragazzi sono interessati alle storie vere. Si interrogano sulla complessità delle mafie e delle loro perverse relazioni con il mondo della politica e delle imprese, del commercio e delle banche, della Chiesa e dello sport. Si chiedono perché i mafiosi opprimono le persone che lavorano onestamente e come riescono a dormine tranquilli, sapendo di fare del male a tanta gente. Come hanno potuto le mafie diventare così potenti, al Sud e al Nord, tanto che oggi pochi sembrano in grado di fare a meno dei loro soldi e dei loro voti.
A.N. Ai giovani cerchiamo di far capire che la mafia è come una tavolozza in cui il bianco e il nero si mescolano continuamente. I buoni e i cattivi, molte volte, finiscono per confondersi, rendendo più complicato il lavoro delle forze dell'ordine. Spesso a farci domande sono i ragazzi che vivono al Nord. A loro bisogna fare capire le mafie al Nord non sono solo la conseguenza del soggiorno obbligato, quella legge che cercava di combattere le mafie, sradicando i mafiosi dai loro territori. Al Nord il mafioso, anziché essere isolato, è stato fatto entrare nei salotti buoni della società.
Ad inizio carriera sognavate di affrontare proprio questo tipo di avventura professionale?
N.G. Io e Antonio Nicaso ci conosciamo da una vita, quando io ancora non ero magistrato e lui non faceva ancora il giornalista. A parte l’amicizia, siamo sempre stati accumunati dalla voglia di evitare le scorciatoie o le raccomandazioni. Siamo sempre stati dell’idea che solo i sacrifici rendono liberi.
A.N. È anche il messaggio che noi cerchiamo di trasmettere ai giovani. La conoscenza e lo studio come arma di riscatto, anche perché i mafiosi temono la scuola più delle maestre.
Quanto la coscienza di compiere una missione in favore della comunità smorza la paura di essere colpiti, e anche pesantemente, dalla malavita? E il sacrificio dell’isolamento quanto pesa? E viene apprezzato? E, semmai, da chi?
N.G. Sono cresciuto, come Nicaso, in una famiglia modesta, ma di grandi valori. La nostra è una scelta di campo. Anche se negli ultimi tempi attorno a noi cresce l’affetto di tante persone oneste che ci ripagano dei molti sacrifici.
A.N. Oggi insegno in una università americana e scrivo libri, proprio come avevo sognato di fare quando, bambino, vivevo ancora in Calabria. Per fare il giornalista sono stato costretto a lasciare l’Italia. È stato difficile, ma allo stesso tempo gratificante. Quel poco che ho fatto, l’ho fatto da solo.
Se una legge antimafia, o addirittura la legislazione anticrimine nel suo complesso, è insufficiente per fronteggiare la malavita organizzata, cosa deve fare un magistrato perché la sua azione sia comunque sostanzialmente efficace sul piano concreto?
N. G. Le leggi si fanno in Parlamento. I giudici le applicano. Il magistrato deve fare il proprio dovere coerentemente, giorno dopo giorno, senza soluzione di continuità. Certo, può anche sperare in un sistema migliore per combattere le mafie, soprattutto nel confronto con altri Paesi. Oggi le mafie si globalizzano. Anche l’antimafia dovrebbe farlo, con l’introduzione di leggi capaci di colpire i mafiosi e i loro patrimoni in ogni angolo del mondo.
Quale deve essere il rapporto fra istituzioni impegnate (non solo la magistratura, ma anche i sindaci o gli amministratori “virtuosi”) e ‘cani sciolti’ (don Aniello Manganiello, il prete anticamorra di Scampia, ad esempio) in modo che le forze non si disperdano?
A.N. Ognuno dovrebbe fare la sua parte. Coloro che gestiscono denaro pubblico dovrebbero tenere più in considerazione gli interessi della collettività. La Chiesa potrebbe e dovrebbe sostenere la voglia di cambiamento, espressa da sacerdoti coraggiosi che in territori difficili praticano quotidianamente il catechismo della legalità. Da sempre, diciamo che, se la Chiesa delle gerarchie ecclesiastiche applicasse ai mafiosi le stesse restrizioni che subiscono i divorziati, forse avremmo malavitosi meno arroganti. Se il Santo Padre scomunicasse i mafiosi, negasse loro i sacramenti, la possibilità di fare i padrini di battesimo o di cresima, darebbe ai preti di parrocchia, ai preti di frontiera il sostegno di cui hanno bisogno. Affermare che i mafiosi con il loro comportamento sono fuori dalla comunità di Dio non basta. Ci sono sempre più mafiosi che vengono insigniti di importanti onorificenze ecclesiastiche e sempre più figli di mafiosi che vengono battezzati in Vaticano. Bisognerebbe fare una seria riflessione. Non si può essere duri con il peccato e tolleranti con il peccatore.
Lo Stato non funziona, il loro ordinamento sì; con loro il guadagno per gli aderenti è assicurato e ai parenti è garantita la sopravvivenza anche quando il capofamiglia muore o è in carcere; il loro sistema economico è efficiente. Sono concetti che spesso si ripetono quando di parla delle organizzazioni malavitose. Ma, al di là delle considerazioni etiche e giuridiche, è così romantica la realtà della malavita organizzata?
N.G. Non è affatto romantica la realtà dei mafiosi. Troppe volte, soprattutto sul piccolo e sul grande schermo, i mafiosi sono stati mitizzati. Noi invece cerchiamo di spiegare ai giovani perché non conviene fare il mafioso, mettendone in evidenza i rischi. I mafiosi sono quasi sempre stressati, vivono continuamente braccati dalle forze dell’ordine e chi entra nei ranghi più bassi non riuscirà mai ad arricchirsi. Anzi correrà il rischio di finire ammazzato o di trascorrere gli anni più belli in carcere.
E come si può convincere un giovane che entrare in una organizzazione criminale non conviene?
A.N. Facendo capire che anche nella mafia ci sono le corsie preferenziali e che solo i figli dei mafiosi fanno carriera. Il resto, la stragrande maggioranza, è carne da macello.
Si dice che la perdita dei valori propria di una società sfrenatamente consumistica favorisca l'attecchire di una cultura di facile conquista del potere e, con essa, l'adesione ad organizzazioni che ti possano agevolare in questo percorso...
N.G. In una società dei consumi, il facile guadagno può diventare lo specchietto per le allodole. Bisogna però considerare che i favori dei mafiosi quasi sempre diventano obblighi. E chi ti dà dieci, poi da te pretende cento.
La globalizzazione è più utile allo sviluppo delle mafie o a chi lotta, o dovrebbe lottare, contro di esse?
A.N. La globalizzazione dovrebbe avere regole comuni per garantire una più equa distribuzione della ricchezza. Ma, in generale, mentre i mafiosi sono riusciti a cogliere questo trend, noi facciamo fatica a superare i limiti della giurisdizione territoriale. C’è ancora molto da fare.
Si discute fortemente sui metodi migliori per indagare, per intervenire, per prevenire, per bloccare. E sull'opportunità di unificare le legislazioni dei vari Paesi e ampliare la loro collaborazione. Cosa è cambiato e cosa dovrebbe cambiare perché la battaglia - che è per molti versi planetaria - dia risultati sempre migliori?
N.G. Qualcosa si muove, soprattutto in Europa. C’è maggiore consapevolezza. Ma, sul fronte della legislazione antimafia, siamo ancora all’anno zero. Per combattere le mafie, bisogna aggredire i capitali mafiosi. E oggi i mafiosi investono dove c’è ricchezza. Spesso lo fanno muovendosi sotto traccia, senza farsi notare, sfruttando la complicità di avvocati, broker, commercialisti. Molti continuano a pensare che le mafie esistano solo quando sparano. E invece bisognerebbe comprendere che sono molto più pericolose quando non usano la violenza, ma fanno ricorso alla corruzione, quando usano i soldi per persuadere chi non è immediatamente predisposto ad aiutarli. Ma non è facile rinunciare ai soldi e ai voti dei mafiosi, soprattutto quando la politica più che servizio è privilegio e soprattutto quando, in momenti di crisi e con la stretta creditizia, i mafiosi sono gli unici ad avere disponibilità economiche, grazie ai soldi della droga, del pizzo e dell’usura.